  |
     |
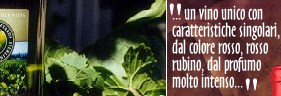    |
 |
 ~~ Allora io, avvicinatomi, parlai al ciclope, tenendo una coppa di vino nero: "Tieni, Ciclope, bevi del vino, dopo aver mangiato carne umana, affinchè tu sappia quale bevanda portava questa mia nave...". Così dicevo e quello prese la coppa e bevve. Molto gli piacque bere la dolce bevanda e ancora ne chiedeva".~~ (dall'Odissea di Omero) IL VINO NOVELLO Il Vino Novello si Produce secondo una particolare tecnica detta macerazione carbonica. Questa tecnica di vinificazione sta nel fatto che i grappoli non vengono pigiati ma messi tutti interi in recipienti ermetici in cui lo spazio libero è riempito con anidride carbonica. La mancanza di ossigeno provoca reazioni particolari (produzione di glicerina e abbattimento di acidi), gli acini iniziano a fermentare e da 5 a 20 giorni si svolge la macerazione a circa 20°/30°; quindi l’uva macerata viene pigiata normalmente e il mosto avviato alla fermentazione alcolica. Si ottiene un vino particolarmente fruttato, subito maturo e pronto per il consumo. E’ un vino gradito ai giovani e alle donne, ed è bene berlo in fretta, entro la primavera; in caso contrario le sue caratteristiche di freschezza si saranno già attenuate lasciando un prodotto ben poco gradevole. di GIOVANNA
CAIANIELLO“MERO” (CASERTA) Il vino è un mediatore
della socievolezza, un rivelatore. I poeti lirici spesso sono poeti del vino: Alceo
associa i due termini in una specie di proverbio: ”Vino e Verità”. Teognide è
più esplicito: ”è col fuoco che gli esperti provano l’oro e l’argento;e
il vino che rivelano l’animo dell’uomo”. Ed Eschilo precisa: ”Il
bronzo è lo specchio di ciò che appare; il vino è lo specchio
dell’anima”.Quindi il vino ha una valenza positiva: restituisce all’anziano
la gioia del vivere lo rende di nuovo socievole. Avvicinandoci all’occidente
ricordiamo, invece, Orazio che è una sorta di Alceo latino, un suo emulo. Egli celebra
il“MERO”(cioè il vino puro dei romani che, essendo prodotto con vendemmia molto
tardiva,era così forte che bisognava miscelarlo con l’acqua) lo scopo è quello di
unire il sangue dei conviviali. Orazio detesta lo sfarzo come il bere smodato, si appaga
di un “modico vinello Sabino”oppure del suo “Cecubo”, bevuto accanto
al fuoco nelle serate invernali, disprezza le ricchezze e le ambizioni per cogliere
“l’attimo fuggente” nelle gioie che esso può offrire, senza curarsi del
domani. Orazio canta le dolcezze del convito letificante, sottolineando la semplicità che
si può godere, senza il bisogno di grandi ricchezze né…di un vino troppo costoso |
|
E-mail:
info@ristorantepresident.it
|
| © 2003-2005 Ristorante President. © 2003-2005 AZTech Studio. All rights reserved. |




